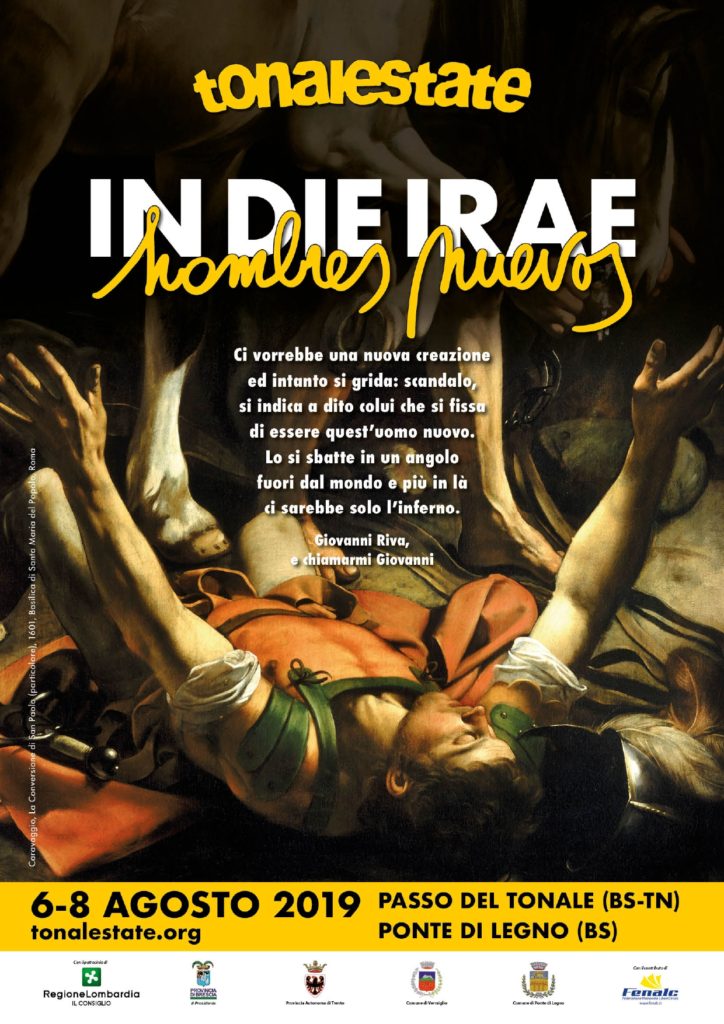In die irae. All’improvviso mi disse una voce…
In die irae.
All’improvviso mi disse una voce…
di Eletta Paola Leoni
Ci limitamo oggi ad analizzare solo la prima parte del titolo del Tonalestate: in die irae, nel giorno dell’ira. Sappiamo che l’ira nasce a causa di un’offesa che ha provocato in noi una tristezza profonda o un’angoscia che non riusciamo a dominare. Petrarca definiva l’ira come “un breve furore”. Dante la vincolava invece al dolore e all’accidia, come aveva imparato dal suo maestro Brunetto Latini che, nel Tesoretto, scriveva: “In ira nasce e posa / accidia nighittosa”. [in italiano dei nostri giorni: Dall’ira nasce e si stabilisce in noi l’accidia che è negliglente]
La nostra sappiamo che è una società molto adirata, che non trova nemmeno nella vendetta una soddisfacente delectatio. Ci prova in mille modi a vendicarsi, ma poi, vedendo che la vendetta non solo non placa l’ira ma nemmeno gli produce tutto il piacere sperato, si lascia andare all’accidïoso fummo (l’espressione è di Dante), cioè s’immerge in un fuoco che lo immobilizza e lo avvolge in una solitudine speciale, mentre ripete, ossessivamente, a se stesso: “Solo io posso proteggermi dall’ira che ho dentro di me e dall’ira che gli altri hanno verso di me”. E in questo modo uno si isola e non fa più nulla di realmente efficace per cambiare positivamente la realtà che lo circonda: dominato dall’ira, cade nell’accidia, per poi esplodere in fulminei atti in cui l’odio esprime tutta la sua enorme violenza (come succede ormai troppo di frequente e non solo negli Stati Uniti).
C’è un’opera di Shakespeare molto famosa, l’Otello. Vale la pena studiarla a fondo, perché l’ira – in quel caso nata in Otello dalle mormorazioni cariche di desiderio di vendetta di Yago – non ci porti mai ad uccidere la persona o le persone chi ci amano. L’essere umano assomiglia molto a Otello e a Yago, mentre sarà sempre un dono inaspettato incontrare chi assomigli a Desdemona, persona immune da ogni malizia.
Ma la frase “in die irae” ci porta anche a riflettere su una parola molto usata ultimamente, la parola Apocalisse, la quale si collega all’idea di un giudizio finale e a un fatidico momento di distruzione cosmica. La paura di essere giudicati la viviamo tutti: noi abbiamo paura che un altro renda pubblici i nostri misfatti e decida come dobbiamo esserne puniti. Questa paura ci spinge a creare dei muri di difesa che col tempo diventano una prigione soffocante e ci tolgono ogni autenticità.
Forse proprio per questo, l’uomo sembra attendere da sempre che succeda qualcosa di talmente distruttivo che ponga fine a tutto, che con fuoco e fiamme azzeri la storia, il passato, e con loro tutto ciò che è esistito ed esiste nel tempo e anche nella propria vita. E vorrebbe decidere lui il giorno, il momento e il modo in cui questo debba avvenire: è una delle tante ubris moderne.
Cerchiamo dunque di vedere di che cosa parliamo quando usiamo il termine Apocalisse. Apocalisse significa svelamento: ciò che non sapevamo ci viene spiegato; quel che non vedevamo cominciamo a vederlo e quel che non sentivamo cominciamo a sentirlo. L’Apocalisse permette dunque che l’ignoto ci diventi noto.
La domanda insita nel cuore umano cui risponde l’Apocalisse potremmo forse riassumerla così: come posso essere felice senza rendere infelici gli altri? L’uomo, per essere felice, ha bisogno di amici. E, per riconoscere chi mi è amico, occorre che io compia un’azione: inginocchiarmi di fronte all’altro. Di fatto Ibis (il nome che l’Islam dà al demonio) rifiutò di inginocchiarsi davanti ad Adamo perché lo giudicava imperfetto e indegno e da lì Ibis perse ogni capacità di amicizia col divino, cioè perse ogni possibilità di essere felice.
Tutti i testi letterari apocalittici (di fatto si tratta di un genere letterario) parlano di un “periodo di corruzione, trasgressione e oppressione da parte di un potere blasfemo e arrogante” e vengono scritte per dare coraggio durante questi periodi di crisi estrema. Iniziano di solito con una visione di speranza, con una voce che chiama, poi, descrivono cataclismi di vario genere, cui segue un nuovo intervallo di speranza e, infine, il trionfo finale. Diventa così, l’apocalittica, una scienza della storia. Questi testi sono numerosi, e andrebbero letti, perché, per dare coraggio e speranza, descrivono sempre il paradiso. E io vorrei soffermarmi più sul paradiso che sulle condanne o i catalismi che pure vi troviamo descritti, perché sono certa che l’albero della vita continuerà a “dare i suoi frutti per l’uomo e le sue foglie per la santità delle nazioni”.
L’idea del Paradiso nacque coi sumeri. Lo chiamarono Dilmun, luogo puro e splendido, luogo rassicurante, riflesso di un’utopia sociale non solo sognata ma che si voleva cominciare a rendere concreta. L’idea si è poi via via arricchita di immagini stupende, spesso anche fantasiose. Un recinto di rose e di mirti, dove si passeggia in compagnia dell’Essere Supremo. Un giardino fiorito dove gli angeli sono a mia disposizione. Il Gan Eden dal clima buono, dall’acqua che abbonda, con frutta, carne e miele. La terra buona ricca di laghi e fiori di loto, dove ognuno indossa abiti splendidi. Un luogo dove il nostro corpo è perfetto, e respira libero in un ambiente di mille colori, fiumi di vino, laghi di burro e dove si mangia di buon appetito. E così via.
Ma il paradiso di Henoc è diverso. Lui racconta: “Michele – cioè un amico – mi prese per mano, mi alzò e mi condusse al santuario misterioso della clemenza e della giustizia. Ho visto la dimora tranquilla dei santi. Lì c’erano preghiere e suppliche a favore di tutti gli uomini. La giustizia passava davanti a loro come un’onda purissima, e la clemenza si diffondeva per la terra come una preziosa rugiada”. E sempre Henoc, vedendo la schiavitù dei dannati, racconta: “Allora io scrissi un’umile supplica a loro favore, perché trovassero riposo e misericordia nonostante tutto il male che avevano fatto”.
Quando dunque il cielo per me svanirà come una pergamena che si arrotola, quale paradiso mi attende? Premesso che, per i nostri sensi, la morte è la più grande delle ingiustizie, bisogna riconoscere che essa crea sempre una disarmonia nella collettività, una disarmonia che facilmente si trasforma in ira, in rancore, in divisioni, lotte e desideri di vendetta. Per vincere questi sentimenti negativi e prepararci al mistero della morte che, per continuare a citare Henoc, trasformerà i nostri sensi rendendoli appieno capaci di Dio, possiamo vivere qualcosa che anticipi quel paradiso, dove appunto trovereremo compiuta l’utopia che abbiamo cercato di vivere già sulla terra.
C’è una parola che potrebbe aiutare in questo cammino di preparazione. Si tratta di una parola che indica un modo d’essere insolito, inusuale, e che i paesi del primo mondo, a causa dei secoli di dominazione violenta che hanno esercitato sugli altri popoli, hanno forse dimenticato. La parola di cui parlo è latina ed è: “mansuetudo”.
Mansuetudo è una parola composta, cioè formata, in questo caso, da due parole: manus/suèscere che possiamo tradurre in italiano con: assuefare la mano. Ad manus venire suetus, dicevano i latini, cioè avvicinare la propria bocca alla mano dell’altro, in un bacio di venerazione.
L’immagine che viene dalla radice della parola è dunque molto efficace, e certo richiede lavoro e fatica quel movimento che fa uscire la nostra mano dalle tasche per porgerla all’altro, in un patto che dice: desidero non ferirti e non tradirti mai.
Come leggiamo nei vangeli, riassumendo antiche saggezze e intuizioni presenti in ogni cultura, i mansueti erediteranno la terra. Ed è vero che solo il mansueto realmente possiede la terra, perché non è più schiavo dell’ossessione di diventare del tutto libero e perché non è più schiavo dell’ossessione di vivere il piacere di comandare e il piacere che gli altri gli obbediscano.
La mansuetudine è dunque l’unica via per scandagliare il totalitarismo che ovunque ci minaccia ed essa ci dà il criterio adeguato per giudicare le nostre azioni personali e anche le azioni dei governi, della società civile e di tutti coloro che operano nel mondo.
E, per concludere, come vedete sul libretto, la giornata di oggi è dedicata, in modo particolare, a uno dei primi passi di questo svelarsi di ciò che non conosco.
Il titolo della giornata di oggi è infatti: “C`è da vergognarsi ad essere felici da soli”. Questa affermazione ci dà un compito: che ogni nostra azione ma anche l’eventuale nostro silenzio non siano mai carichi d’ira e di rancore, ma siano sovrabbondanti di compassione e di domanda.
D’altra parte, se, anni fa, ci veniva richiesto il coraggio dell’indignazione, il nostro tempo ci richiede invece il coraggio di un candore prodigo, vigoroso e vitale.