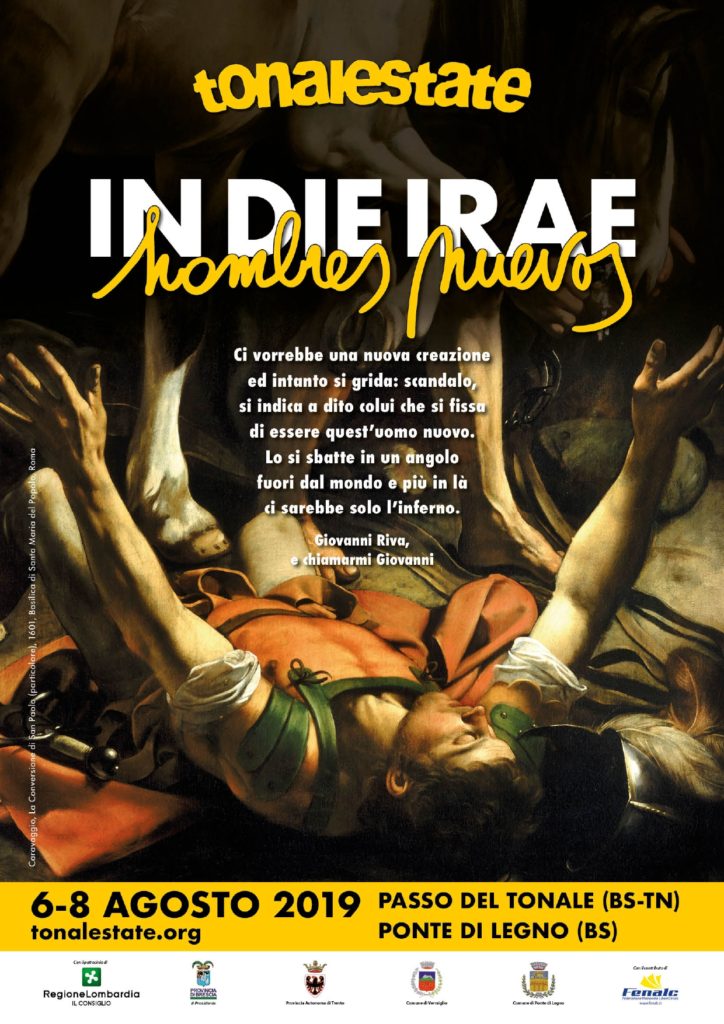Messaggio a Tonalestate 2016
Marcello Semeraro
Carissimi Amici raccolti per il Tonalestate 2016, vi raggiungo volentieri col mio saluto e con l’augurio che i giorni trascorsi insieme tra voi siano gioiosi e ricchi di bene. Il tema scelto per il vostro incontro ha il suo asse sulla parola eredità, da cui nasce una domanda molto seria: cosa possiamo lasciare in eredità ai nostri figli? È l’interrogativo che vi è posto. C’è un intervento molto interessante riguardo a tale formulazione della domanda, scritto da Barbara Spinelli sul quotidiano «La Repubblica» del 26 maggio 2011. Ella riflette sulla metafora della corsa a staffetta e sulle modalità prescritte per lasciare il «testimone». Anzitutto, ella osserva, questa consegna deve avvenire attraverso un «contatto»; d’altra parte, essa implica un «lasciare», un distaccarsi. La Spinelli introduce, quindi, una bella immagine biblica e scrive: «Ereditare non è impossessarsi, ma esperire il vuoto, la separazione, la vedovanza. Un ereditare spirituale, come quello del profeta Eliseo che chiede ad Elia, prima che questi sia rapito al cielo: “Due terzi del tuo spirito siano in me”. Ed Elia risponde che questi due terzi sono “cosa difficile”, ottenibili a una condizione: che Eliseo colga l’Occasione, quando si presenterà, e guardi Elia strappato verso il cielo. Che si faccia veggente di cose che vengono tenute nascoste, che dica quello che altri non dicono. Perché si possa “ereditare”, occorre aver sentito il vuoto come terribile cesura, senza nascondere il trapasso, e “aver visto”, in anticipo, l’inizio di una nuova corsa. Occorre che nel passaggio l’erede sia stato toccato, sia stato designato, perché questi non si senta un diseredato».
Oggi, però (ed eccoci ad una grave criticità), c’è davvero la volontà di trasmettere, di avere degli eredi? Al riguardo sembra onesto riconoscere alla generazione presente una buona dose di autoreferenzialità. «La specificità di questa generazione – ha scritto un Autore, che tornerò a citare – è che i suoi membri, pur divenuti adulti o già anziani, padri o madri, conservano in se stessi, incorporato, il significante giovane. Giovani come sono stati loro, nessuno potrà più esserlo – questo pensano. E ciò li induce a non cedere nulla al tempo, al corpo che invecchia, a chi è arrivato dopo ed è lui, ora, il giovane. Come sempre, il lavoro del lutto non compiuto è stato addebitato alla generazione successiva» (F. Stoppa, La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, Milano 2011, 9-10). Il rimprovero non è tanto quello di non lasciare alle nuove generazioni nulla da «ereditare», ma di non avere fatto nulla perché l’«erede» possa, o riesca, a fare propria l’eredità. L’idea generale è che un compito di chi educa non è solo lasciare in eredità dei valori, ma anche mettere l’altro in condizione di acquisirli e accrescerli a sua volta. Vi affido, dunque, alcune riflessioni, nella speranza che vi siano di una certa utilità; la mia, ad ogni modo sarà, anche se in forma scritta, una voce che desidera unirsi alle vostre.
Per stare al tema, comincerei col citarvi un’espressione divenuta famosa, se non altro perché è stata ripresa più d’una volta da Freud. È ripresa da Goethe, che pone sulle labbra del suo Dr. Faust queste parole: Was du ererbt von deinen Vätern hast / Erwirb es, um es zu besitzen, «Quello che hai ereditato dai tuoi padri, riconquistalo, se davvero vuoi possederlo» (Faust, p. I, sc. I [Nacth], 682-683). Non entro in merito al lungo monologo, durante il quale Faust, che ambisce ad una nuova conoscenza, recrimina contro un vecchio alambicco, un tempo appartenuto al padre e mai usato, ed esclama: «Quel poco che possiedo l’avessi scialacquato, invece di sudare sotto il peso del poco!». Sono i versi che immediatamente precedono quelli più famosi, che ho citato.
«Ereditare» è un verbo che non si deve mentalmente coniugare al passivo, ma all’attivo. Non ci si può, infatti, limitare a ricevere un bene ma occorre accoglierlo e farlo proprio con un gesto di apertura consapevole, libera e disponibile. Ecco, dunque, l’asserto davvero importante: quello che hai ereditato dai tuoi padri, riconquistalo, se davvero vuoi possederlo. La sua validità appare tutta allorquando si tratta di valori spirituali e morali. Sotto questo profilo non si è mai «figli d’arte»! Se lo si diventa, accade sempre mediante un faticoso lavoro di riappropriazione, di rielaborazione, di interiorizzazione. Di scelte. Vale anche per quella straordinaria «eredità» che si chiama fede. Anche nel senso inteso da Tertulliano che polemizzava: fiunt, non nascuntur christiani, «cristiani si diventa, non si nasce» (Apolog. 18: PL 1, 378).
Solo nelle scelte consapevoli e aperte al futuro le eredità rivivono. Anche per questo, si trasformano e fruttificano. Massimo Recalcati ne ha opportunamente parlato come di una riconquista: «L’eredità non è l’appropriazione di una rendita, ma è una riconquista sempre in corso» (Il complesso di Telemaco, Milano 2013, 123). L’eredità, dunque, se accettata è uno sguardo in avanti, un impegno, una responsabilità. Occorre, allora, essere (per citare ancora Recalcati) degli «eredi giusti», degli eredi capaci. Non basta, diremmo, essere «figlio di re» per potere diventare un buon re! Si potrebbe, in proposito, pensare a quell’enigmatico detto evangelico che dice: del Regno di Dio se ne impadroniscono i violenti (cf. Mt 11, 12). Al di là di ogni altra esegesi si potrebbe interpretare col dire che entrare nel Regno non è un fatto notarile e di naturale successione, ma di una scelta forte ed energica, anzitutto su se stessi. In ogni caso, una scelta gravida di futuro.
Di «eredità» trattava san Paolo a Timoteo, quando scriveva: «custodisci ciò che ti è stato affidato» (1Tm 6,20). L’attenzione dell’Apostolo è concentrata sulla custodia e sulla difesa da ciò che può adulterarne il contenuto. Un classico testo del V secolo ha glossato con queste parole: Aurum accepisti, aurum redde, «Tu hai ricevuto dell’oro, restituisci dunque oro. Tu non puoi impudentemente sostituire l’oro con del piombo» (Commonit. XXII: PL 50, 667). Con ciò, Vincenzo di Lerino, che è l’autore dello scritto, metteva in evidenza non tanto la persistenza materiale dell’oggetto ricevuto in consegna (che di per sé potrebbe anche oggettivamente variare) ma la sua «preziosità» che, al contrario, deve essere valorizzata e accresciuta. Nella parabola evangelica dei talenti affidati ai servi, quello condannato è il servo che ha nascosto sotterra il talento ricevuto e lo restituisce tale e quale (cf. Mt 25, 26-27). Quel che si è ricevuto in eredità non può essere svilito, depauperato, accantonato, ma deve essere tesaurizzato.
In 1Cor 11, 23 e 15, 3, tuttavia, vediamo posto in evidenza un altro aspetto dell’ereditare: il dinamismo del ricevere-trasmettere. In rapporto alla narrazione celebrativa dell’Eucaristia e alla consegna del nucleo centrale del simbolo di fede, Paolo sottolinea: consegno quello che ho ricevuto! Non c’è autentica recezione senza trasmissione. Ricevere senza la volontà di trasmettere è accaparramento, volontà di possesso e non un ereditare.
Ogni accoglienza deve essere un’apertura al futuro, un segno di speranza e di vita per chi verrà dopo. Accoglie davvero chi è disposto a trasmettere. Altrimenti sarebbe accaparramento. Ereditare, infatti, vuol dire non soltanto acquisire dei beni, comunque siano, ma pure collegarsi, in un modo o nell’altro, a una storia, a una vita.
Per altro verso, anche il consegnare una eredità esprime almeno il desiderio di una sopravvivenza. Dare una eredità significa volere che non sia posta una pietra sul passato, non mettere la parola «fine»; è un affidamento a chi verrà dopo e un «fidarsi» di lui, nonostante tutto. È, dunque, uno sguardo oltre se stessi. Rifiutare o svilire una eredità, al contrario, è mettere una barriera, una chiusura.
L’importanza della «restituzione» come appuntamento tra le generazioni da non mancare si trova opportunamente rilevata e bene descritta nel lavoro di Francesco Stoppa che ho citato in principio. Significato del restituere, egli spiega, non è propriamente il dare in contraccambio, quanto mettere nuovamente in relazione, rimettere in circolo qualcosa di antico e di valido perché sia rinnovato. Si tratta, appunto, del patto intergenerazionale.
Non è questione dappoco. Se n’è interessato anche e a più riprese papa Francesco. Parlando a Torino nel corso di un incontro col mondo del lavoro il 21 giugno 2015 disse: «Vorrei unire la mia voce a quella di tanti lavoratori e imprenditori nel chiedere che possa attuarsi anche un “patto sociale e generazionale”». Appena un mese prima, nel corso dell’Udienza generale del mercoledì 20 maggio 2015 si era domandato: Quale tradizione abbiamo oggi da trasmettere ai nostri figli? La risposta fu: «Intellettuali “critici” di ogni genere hanno zittito i genitori in mille modi, per difendere le giovani generazioni dai danni – veri o presunti – dell’educazione familiare. La famiglia è stata accusata, tra l’altro, di autoritarismo, di favoritismo, di conformismo, di repressione affettiva che genera conflitti. Di fatto, si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola, il patto educativo oggi si è rotto; e così, l’alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in crisi perché è stata minata la fiducia reciproca». Quest’ultimo passaggio si ritrova al n. 84 dell’esortazione apostolica Amoris laetitia.
F. Stoppa legge suggestivamente il patto intergenerazionale come «consegna del mistero di ciò che ci fa uomini, il passaggio di qualcosa che, per quanto non sia misurabile né concretamente palpabile, rappresenta pur sempre la chiave che ci consente di tenere aperto per noi stessi e per i nostri legami un orizzonte di senso non riducibile alla sopravvivenza individuale o alla soddisfazione dei bisogni personali (direzione in cui invece spinge la morale moderna)» (p. 239). Si tratta, in definitiva, «della reciproca disponibilità a riconoscere il proprio limite e il posto, o meglio, la realtà dell’altro» (p. 240). Il gesto, difatti, di non trattenere per sé, ma di consegnare, di trasmettere simbolizza, testimonia e compie in ultima analisi un gesto di profonda umiltà; povertà se vogliamo, se la consideriamo alla luce di Cristo che «dona», «trasmette» se stesso in un atto di kenosi totale: «svuotò se stesso», leggiamo in Fil 2, 7. Anche il «ricevere», d’altra parte, è segno di una analoga umiltà, poiché esprime il sentito bisogno dell’altro e la consapevolezza della propria radicale indigenza. «Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto?» (1Cor 4, 7). Questa umiltà reciproca può essere un efficace collante per tenere insieme le generazioni, quelle che donano e quelle che ereditano. «La generazione sta da sola. Le sono compagne la de-generazione e la ri-generazione», esordisce G. Zagrebelsky nel suo Senza adulti (Torino 2016, VII) e continua: «La vita è una continua degenerazione cui si accompagna la ri-generazione, e la ri-generazione contiene in sé due fattori, uno mortale e uno vitale, l’uno che uccide qualcosa del vecchio e l’altro che vivifica qualcosa del nuovo. Dove non c’è rigenerazione non c’è vita. Se non c’è lo spegnimento della vita, c’è soltanto il durare, l’esistere, il sopravvivere ».
Può essere applicato al binomio trasmettere/ricevere, che più radicalmente ha il suo senso pieno nella parola di Gesù: «In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12, 24). Accogliere «una eredità» vuol dire entrare nel mistero di una vita donata. È il mistero di Cristo e della Chiesa, mirabilmente espresso da Tommaso d’Aquino nei versi dell’Inno Verbum supernum: «Nascendo per noi ci ha donato la possibilità di essere comunione; dando la vita per noi ci ha dato la libertà» (Se nascens dedit socium … se moriens in pretium). È la Chiesa, comunione di uomini liberati e liberi per avere accolto Cristo in eredità. In Lui siamo stati fatti eredi (Ef 1, 11).
Marcello Semeraro, vescovo di Albano