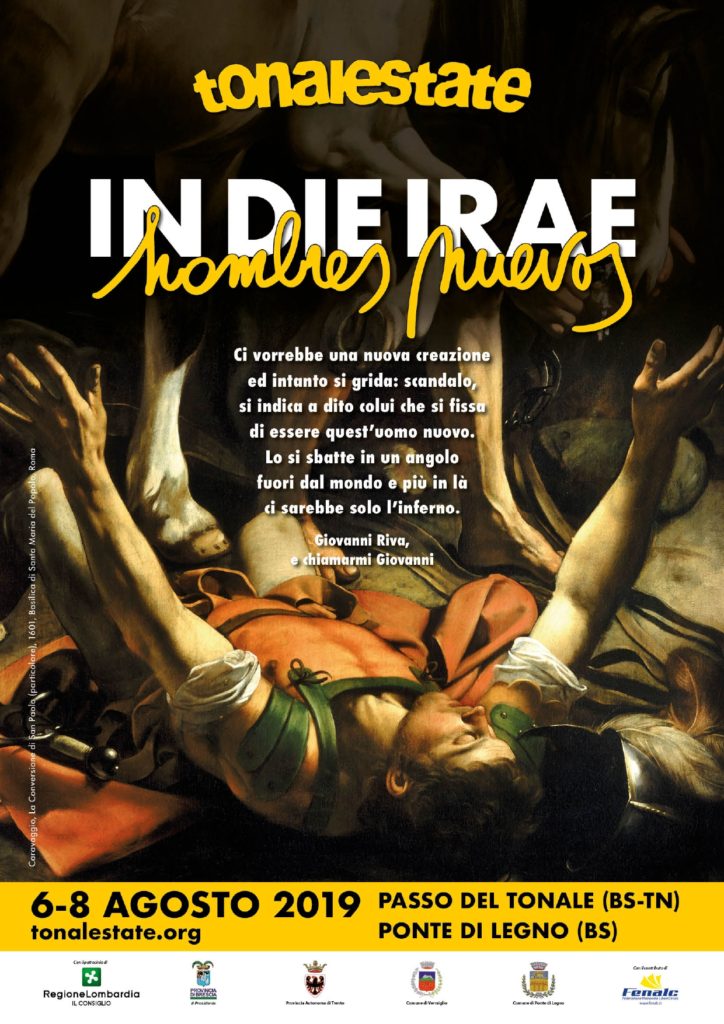Parole per dire l’indicibile del male
9 Agosto 2011 Nessun Commento
17 maggio 1975 Phnom Penh, Cambogia. 7 aprile 1994, Kigali, Rwanda.
Due bambine affrontano, in quelle due date, l’abisso dell’orrore.
Beata Uwase, aveva cinque anni in quell’aprile del 1994. Nel suo primo giorno di scuola il maestro chiede ai bambini tutsi di dichiarare la loro appartenenza alzandosi in piedi. Lei non sa rispondere e quando chiede alla madre non riceve risposta ma soltanto di non alzarsi. Capirà il perchè di quel silenzio in quella giornata d’aprile, quando i militari irrompono nella sua vita massacrando, nella sua casa, la sua famiglia. Lei rimane gravemente ferita e viene soccorsa da un vicino di casa di etnia Hutu: la nasconde e la cura, ma presto capisce che senza un ospedale sarebbe morta. Facendola passare per la figlia la lascia in ospedale in custodia a un’infermiera che la proteggerà fino all’assalto successivo in cui rimane nuovamente sola e fuggitiva. Dopo diversi giorni di cammino, sola, senza niente da mangiare, dormendo dove capitava, arriva a nord del Rwanda e viene soccorsa da una nuova famiglia hutu anch’essa in fuga dalla guerra. Diviene parte di loro ma tace la sua identità. “Un interhamwe tra i venti e trent’anni, iniziò a sospettare che fossi una tutsi e non smetteva mai di minacciarmi. Io ero spaventata, quando lo vedevo correvo a nascondermi. Mi chiamava scarafaggio, serpente, e appena poteva discuteva con le persone della mia nuova famiglia, gli diceva che a causa di scarafaggi come me loro erano stati costretti ad abbandonare il paese e che se non mi avessero consegnata, gli interhamwe li avrebbero ammazzati tutti”. Fortunatamente Beata ha poi avuto la possibilità di poter arrivare in Italia, di potersi curare, trovare una famiglia e iscriversi all’Università dove studia medicina. Intende andare avanti oltre la mentalità della divisione tra le persone per riscoprire il valore dell’umanità.
Navy Soth è nata in un piccolo paesino della giungla cambogiana. E’ una dei sopravvissuti al genocidio del suo popolo durato oltre 30 anni che ha causato 5 milioni di morti. I khmer rossi Navy li chiama i “pigiami neri”: entrarono nella sua casa rastrellando la famiglia e costringendola alla deportazione. Una bimba piccolissima viene privata del nome- tutti dovevano soltanto chiamarsi “compagni”- costretta a marce nella giungla, spettatrice della morte di anziani, bambini, e di tutti coloro che non reggevano ai lavori forzati o, semplicemente, prendevano una qualche iniziativa come il costruirsi una canna da pesca. Troppo piccola per lavorare, era abbandonata ogni mattina e si faceva strada nella giungla alla ricerca di qualche verme o serpente per avere qualcosa con cui giocare e qualcosa da mangiare. “il giorno che hanno ucciso mio padre mi hanno impedito di piangere, ci avevano tolto anche questo e io ho cercato di fissarmi negli occhi mio padre che partiva…come mi è rimasto il ricordo di una mia sorella che mi supplicava di darle qualcosa da mangiare per non morire di fame”. Navy dice di aver avuto un’educazione da genocidio e di aver pensato che quella era la vita, fino al giorno che osservò il volo di una farfalla e immaginò possibile anche altro.
Perchè hanno commesso contro di loro l’impensabile? Navy dice che non hanno mai trovato una risposta logica nè una qualsiasi risposta e, oggi, costituendosi parte civile al processo che verrà celebrato contro alcuni dei responsabili, dice di non avere interesse alla loro condanna ma di avere il bisogno di sapere il perchè e di voler fare memoria di chi nessuno ha mai più ricordato, abbandonato in quell’inferno.