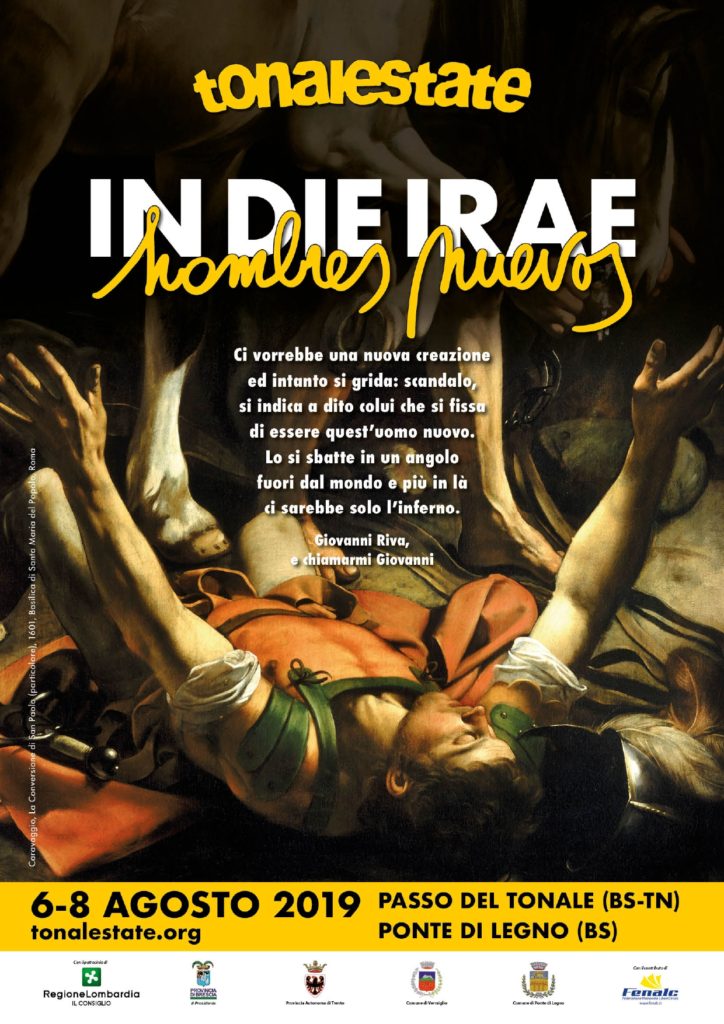Come l’uom s’etterna. L’evoluto selvaggio
 Tonalestate, giunto alla decima edizione, si svolgerà anche quest’anno, dal 4 al 7 agosto 2009, al Passo del Tonale (TN) e a Ponte di Legno (BS). Mentre, nella ricorrenza darwiniana, si discute di evoluzione a livello delle scienze, Tonalestate vorrebbe fare notare come l’uomo, quali che siano le sue origini, rincorra, da una parte, il meglio e stia, però, anche mostrando, da un’altra parte, di non essere ancora “disceso” del tutto da qualche primitivo animale selvaggio, poiché sta riempiendo la terra e la storia, anche oggi, di ingiustizie, guerre, stragi, eccidi, violenze e massacri che nulla hanno da invidiare alla bestialità. Il momento di approfondimento sarà dunque da cogliere nel risvolto umano e culturale di una evoluzione del “bipede implume” che non è spontanea né naturalistica, ma che esige il rischio della volontà. Il titolo, per segnalare l’aspetto positivo della negatività dell’uomo quale “evoluto selvaggio”, è rubato a un verso di Dante: “Come l’uom s’etterna”. Le parole che il poeta dedica al suo maestro Brunetto Latini, nel canto XV dell’Inferno, indicano lo stato di creazione continua nell’uomo, che “si fa eterno” con le opere buone che dimostra con la vita; vi è la possibilità per l’uomo di una realizzazione piena, completa, una vita nuova. Infatti, ciò che differenzia ontologicamente l’uomo dagli altri animali è un’apertura all’infinito, all’assoluto, a un destino di amicizia definitiva con il creato. Nel dialogo di Tonalestate, perciò, entreranno in gioco senza dubbio i passaggi di quella trasformazione paolina e giovannea che tende verso il sublime, verso l’infinito. Pur nel dolore cui è destinata la vita dell’uomo è possibile la realizzazione di una corrispondenza amicale con l’universo e con la storia. In questo senso deve essere intesa la poesia di Pär Lagerkvist che accompagna il tema di Tonalestate. Il poeta svedese, premio Nobel nel 1951, nel suo acume di intelligenza scrisse questi versi per dirci che dentro ogni uomo esiste questa voce, questa tensione che fa parte della sua struttura, del suo essere. Una voce che grida a uno sconosciuto: perché sono nato? Perché devo lottare? Perché devo amare? E morire? Il dio che non esiste, il terribile dio, è lì, nella mia anima. C’è nell’uomo questo marchio ineliminabile, una domanda che diventa grido: “Perché giace una creatura nel fondo delle tenebre e invoca qualcosa che non esiste?”. Perché l’uomo vive nella disperazione, al buio e grida aiuto a qualcosa che non esiste? Se io dico che non esiste questo infinito, perché sorge questa domanda? Lo posso chiamare con qualsiasi nome: Allah, Dio, Cristo, mistero, lo posso chiamare in qualsiasi modo, ma ciò che voglio esprimere è qualcosa che supera me e l’altro come me, ed è Altro più grande. L’uomo allora, che pur non essendo infinito, cerca l’infinito, sarebbe un assurdo, perché avrebbe dentro una domanda cui non c’è risposta. Ma proprio qui sta il valore dell’uomo, il vertice massimo della sua realizzazione: nella sua domanda di realizzazione. Egli, creatura animale, è però capace di entrare in rapporto e in dialogo personale con l’increato; si riconosce realizzato soltanto nell’infinito e nell’assoluto. L’umano, per essere tale, esige l’assoluto. L’uomo deve forse riconoscere di avere bisogno di “altro” che lo renda veramente uomo, poiché, naturalisticamente, egli resterebbe allo stato selvaggio e bestiale, violento e aggressivo (l’uomo non è infinito, non è divino), tanto che anche oggi, all’alba del terzo millennio, vediamo l’uomo (che si dice “evoluto”) utilizzare addirittura il progresso scientifico e tecnico per prevaricare sull’altro uomo e sulla natura. Come Abele e Caino raffigurati da Marc Chagall in questa litografia che fa parte del ciclo di Disegni della Bibbia (del 1960), l’uomo, naturalisticamente e istintivamente, sarebbe portato solo alla violenza sull’altro uomo, suo fratello. L’argomento potrà vedere un dialogo costruttivo e rispettoso, che valorizzi tutti gli aspetti dell’esistere umano nella sua totalità, dalla filosofia alla religione alla politica, dal pluralismo, alla pace, alla solidarietà all’economia e al lavoro.
Tonalestate, giunto alla decima edizione, si svolgerà anche quest’anno, dal 4 al 7 agosto 2009, al Passo del Tonale (TN) e a Ponte di Legno (BS). Mentre, nella ricorrenza darwiniana, si discute di evoluzione a livello delle scienze, Tonalestate vorrebbe fare notare come l’uomo, quali che siano le sue origini, rincorra, da una parte, il meglio e stia, però, anche mostrando, da un’altra parte, di non essere ancora “disceso” del tutto da qualche primitivo animale selvaggio, poiché sta riempiendo la terra e la storia, anche oggi, di ingiustizie, guerre, stragi, eccidi, violenze e massacri che nulla hanno da invidiare alla bestialità. Il momento di approfondimento sarà dunque da cogliere nel risvolto umano e culturale di una evoluzione del “bipede implume” che non è spontanea né naturalistica, ma che esige il rischio della volontà. Il titolo, per segnalare l’aspetto positivo della negatività dell’uomo quale “evoluto selvaggio”, è rubato a un verso di Dante: “Come l’uom s’etterna”. Le parole che il poeta dedica al suo maestro Brunetto Latini, nel canto XV dell’Inferno, indicano lo stato di creazione continua nell’uomo, che “si fa eterno” con le opere buone che dimostra con la vita; vi è la possibilità per l’uomo di una realizzazione piena, completa, una vita nuova. Infatti, ciò che differenzia ontologicamente l’uomo dagli altri animali è un’apertura all’infinito, all’assoluto, a un destino di amicizia definitiva con il creato. Nel dialogo di Tonalestate, perciò, entreranno in gioco senza dubbio i passaggi di quella trasformazione paolina e giovannea che tende verso il sublime, verso l’infinito. Pur nel dolore cui è destinata la vita dell’uomo è possibile la realizzazione di una corrispondenza amicale con l’universo e con la storia. In questo senso deve essere intesa la poesia di Pär Lagerkvist che accompagna il tema di Tonalestate. Il poeta svedese, premio Nobel nel 1951, nel suo acume di intelligenza scrisse questi versi per dirci che dentro ogni uomo esiste questa voce, questa tensione che fa parte della sua struttura, del suo essere. Una voce che grida a uno sconosciuto: perché sono nato? Perché devo lottare? Perché devo amare? E morire? Il dio che non esiste, il terribile dio, è lì, nella mia anima. C’è nell’uomo questo marchio ineliminabile, una domanda che diventa grido: “Perché giace una creatura nel fondo delle tenebre e invoca qualcosa che non esiste?”. Perché l’uomo vive nella disperazione, al buio e grida aiuto a qualcosa che non esiste? Se io dico che non esiste questo infinito, perché sorge questa domanda? Lo posso chiamare con qualsiasi nome: Allah, Dio, Cristo, mistero, lo posso chiamare in qualsiasi modo, ma ciò che voglio esprimere è qualcosa che supera me e l’altro come me, ed è Altro più grande. L’uomo allora, che pur non essendo infinito, cerca l’infinito, sarebbe un assurdo, perché avrebbe dentro una domanda cui non c’è risposta. Ma proprio qui sta il valore dell’uomo, il vertice massimo della sua realizzazione: nella sua domanda di realizzazione. Egli, creatura animale, è però capace di entrare in rapporto e in dialogo personale con l’increato; si riconosce realizzato soltanto nell’infinito e nell’assoluto. L’umano, per essere tale, esige l’assoluto. L’uomo deve forse riconoscere di avere bisogno di “altro” che lo renda veramente uomo, poiché, naturalisticamente, egli resterebbe allo stato selvaggio e bestiale, violento e aggressivo (l’uomo non è infinito, non è divino), tanto che anche oggi, all’alba del terzo millennio, vediamo l’uomo (che si dice “evoluto”) utilizzare addirittura il progresso scientifico e tecnico per prevaricare sull’altro uomo e sulla natura. Come Abele e Caino raffigurati da Marc Chagall in questa litografia che fa parte del ciclo di Disegni della Bibbia (del 1960), l’uomo, naturalisticamente e istintivamente, sarebbe portato solo alla violenza sull’altro uomo, suo fratello. L’argomento potrà vedere un dialogo costruttivo e rispettoso, che valorizzi tutti gli aspetti dell’esistere umano nella sua totalità, dalla filosofia alla religione alla politica, dal pluralismo, alla pace, alla solidarietà all’economia e al lavoro.
TONALESTATE 2009 L’EVOLUTO SELVAGGIO di Eletta Leoni Studenti, universitari, giovani e non più giovani, provenienti da vari Paesi del mondo, uniti da una passione – quella di essere parte creativa di un’amicizia duratura – si trovano, anche quest’anno, al Passo del Tonale, per una breve vacanza. Si sono dati, da sempre, un nome: “Compagnia”, il cui significato etimologico – “cum panis” – già indica qualcosa di più di un semplice riunirsi. “Condividere il pane” indica una scelta e una decisione: mettere insieme ciò da cui l’uomo non può prescindere e che gli è vitale per poter continuare a dirsi uomo. Dunque, si tratta di una straordinaria e inusuale esperienza. Il Tonalestate è un luogo dove la cultura è un piccolo grande popolo che cammina insieme. Personalità del mondo artistico, letterario, religioso e scientifico, sociale e del volontariato non vengono chiamati a sfilare su una passerella culturale: al contrario, si incontrano a tu per tu con gli altri, per porsi domande e vivere uno spazio che desidera aiutare l’uomo e il mondo a scrivere, se possibile, su righe un po’ meno storte o confuse la sua storia. L’intelligenza dei temi scelti dal Tonalestate sta in ciò che è tipico dell’avanguardia vera, cioè ogni parola nasce da un vissuto. Dietro a Tonalestate c’è, infatti, una vita quotidiana, un’esperienza che dialoga costantemente con la realtà e alcune parole tanto alla moda come successo e insuccesso, o come merito e demerito, sono state eliminate dal suo vocabolario. Il tema del Tonalestate per il 2009 è “L’evoluto selvaggio”.
Come breve introduzione al tema, partiamo dalla lucida sentenza sull’uomo fatta da Stanley Kubrik: “L’uomo non è un buon selvaggio, è un cattivo selvaggio: è irrazionale, brutale, timoroso, stupido e in più incapace di essere oggettivo, quando i suoi interessi sono coinvolti”. arriva, invece, quasi a rispondergli dal passato, la voce di un buon selvaggio: è un canto che giunge dall’America dell’800. Walt Whitman, poeta della rigogliosa eternità, contempla il mondo futuro – non più lacerato dalla dolente guerra – rendersi esperto di una possibile e sana riconciliazione (“parola sopra ogni altra, bella come il cielo” dice il poeta):“Bello che la guerra e tutte le sue gesta di carneficina debbano con il tempo andare interamente perdute/Che le mani delle sorelle Morte e Notte/ incessantemente dolcemente lavino di nuovo e ancora di nuovo questo mondo insozzato”. Kubrik, per nulla commosso alla visione incantevole, risponde, dal nostro oggi, che: “Ogni tentativo di creare istituzioni sociali su una falsa visione della natura dell’uomo è destinata a fallire”. Il Tonalestate parla di un selvaggio “evoluto”, sottolineando, così, il fatto che l’uomo dei nostri tempi è un selvaggio che si è messo il frack, che si è posto una divisa, per autoconvincersi di non essere più un selvaggio, di non essere più come quell’elefante che, trovandosi in un negozio di oggettini fragili, non può far altro che romperli. L’uomo, camuffato da civilizzato, paga di fatto molto caro il suo rompere l’intorno, perché gli restano in mano cocci di cui non ricorda né la bellezza né il senso. Ma dobbiamo ora analizzare la parla chiave, cioè la parola “selvaggio”.
IL SELVAGGIO Il dizionario dell’Accademie Française del 1694 chiamava ”sauvages” (selvaggi) quei popoli che vivevano nelle foreste “senza fissa dimora, più come bestie che come uomini”. E, sempre sul limitare del secolo XVIII, per indicare coloro che la civiltà non aveva raggiunto e doveva raggiungere, si sostituiva spesso la parola “sauvage” (selvaggio) col termine “barbare” (barbaro). Il barbaro (in greco letteralmente “il balbuziente”, cioè chi aveva difficoltà nel pronunciare la lingua greca) era per i greci lo straniero che doveva lasciarsi trasformare dalla cultura ellenica, tanto che l’ellenismo divideva l’ umanità tra elleni (civilizzati) e barbari (incivilizzati). Per i latini, il barbaro era lo straniero che viveva in terra di conquista: bisognava sconfiggerlo sul campo di battaglia o comunque annetterlo all’impero. Lévi-Strauss, per il quale è barbaro l’uomo che massacra gli alberi per farne dei bastoni, sostiene, ne Il pensiero selvaggio, che non esistono steccati tra i popoli detti primitivi e i popoli detti civili; ma, per lui, il più riconosciuto etnologo del secolo XX, l’ uomo non è di molta importanza: “L’uomo” – Lévi-Strauss dichiarerà a un giornalista– “può anche sparire: solo le opere d’arte sono insostituibili».
IL MITO DEL BUON SELVAGGIO “Noi siamo innocenti, noi siamo felici”: a pronunciare queste parole è un anziano abitante di Tahiti, nelSupplemento al viaggio del signor di Bougainville, un’opera del 1772 il cui autore è l’enciclopedista Denis Diderot. Il mito del buon selvaggio raggiunge il suo apice proprio alla fine del 700 e ci presenta uomini che vivono in una specie di società perfetta, non contaminata dal delitto, capaci di armonia con la natura, generosi e altruisti, innocenti, estranei al mentire, disdegnosi della lussuria, dotati di coraggio, salute, intelligenza innata e spontanea. Quella della tribù-società perfetta si tratta, per molti aspetti, di un’invenzione indotta più che di una realtà di fatto. E’ però il segno che alcuni viaggiatori, liberi per un momento da mire coloniali, vedevano in questi paesi per loro esotici qualcosa di “diverso”. Questo mondo diverso, che viveva secondo altre regole, era capace di suscitare nel viaggiatore la nostalgia di un’infanzia felice, di un esserci alla vita non contaminato e di un’apertura dei polmoni a un respiro pacificato.
IL MITO DEL CATTIVO SELVAGGIO Al mito del buon selvaggio si contrappone il mito del cattivo selvaggio. Voltaire cita nel suo Dictionnaire philosophique (1764) diversi casi di selvaggi che mangiano il nemico ucciso in combattimento. Anche nell’Ingénu si ritrovano simili casi di cannibalismo, in cui gli uroni e i selvaggi d’America appaiono del tutto privi di limiti. Un recente saggio, pubblicato negli Stati Uniti, sostiene che “fra i popoli primitivi, nelle società precolombiane, fra gli eschimesi, gli indigeni di Oceania e le tribù africane, la guerra era incessante e senza pietà. Nelle guerre primitive, i guerrieri catturati venivano uccisi sul posto, salvo il caso degli irochesi, che conducevano i prigionieri al villaggio per torturarli fino alla morte, e certe tribù della Colombia che preferivano ingrassare i prigionieri per poi mangiarli”.
IL MITO DEL SELVAGGIO, OGGI Oggi il mito del cattivo selvaggio va prendendo sempre più piede ed è, purtroppo, il pretesto per stigmatizzare i più poveri fra i nostri contemporanei: primi fra tutti, si considerano come cattivi selvaggi, censurandone i costumi e le speranze, coloro che fuggono dalla loro terra di miseria per cercare rifugio in un Eden che i potenti han deciso che non sia il loro e che poi nemmeno Eden è. Contro l’emigrato, l’extracomunitario, lo straniero, l’indigeno, l’appartenente all’una o all’altra minoranza etnica, si fomenta il mito del cattivo selvaggio che deve essere rieducato e che costituisce un pericolo e uno scandalo per la società del benessere. A questi ritenuti cattivi selvaggi, seguono poi tutti gli altri (cattivi selvaggi anch’essi, secondo la logica del potere), che non hanno ancora imparato o decisamente non vogliono imparare le buone maniere. Soprattutto si considerano barbare le persone intelligenti, perché sono indomabili nei loro tentativi di cambiare le cose e perché normalmente sono poveri: intelligenza e povertà si danno da sempre la mano e da sempre sono considerate una colpa. Il potere dei pochi o la gran massa dei pettegoli annoiati senza ideali finiscono sempre per ammazzare il barbaro, che è d’intralcio ai loro affari e alla loro stupidità.
CAINO E ABELE Il racconto è questo: Caino, un giovane pieno di zelo e di iniziativa, sospinto da un’interessante ansia creativa, ma anche pieno di paura e di nascosti pensieri, ammazza suo fratello per un calcolato moto d’ira, d’invidia, di ambizione e di gelosia. Così, Abele, il giusto, muore ucciso per mano di un prossimo di cui poteva fidarsi. E il Dio detta la sua sentenza: Caino sarà un giovane errante, ma porterà su di sé un segno che lo proteggerà da chi vorrà ripetere, contro di lui, lo stesso suo delitto. Tutti si sono posti, qualche volta, almeno due domande: perché quel Dio non accettava mai i doni di Caino e sempre accettava quelli di Abele? E perché Caino sfogò il suo rancore contro suo fratello invece di discutere e protestare col Dio? Il racconto è chiaramente emblematico e vuole insegnare che, per vivere pienamente, per “evolversi” cioè crescere, maturare, rendersi adeguato alla sua stessa natura, l’uomo ha bisogno di conoscere regole che sono in lui, però che non ha stabilite lui. Potrà l’uomo uccidere tutti coloro che gli ricordino le leggi dell’essere, ma non potrà mai uccidere tali leggi e vagherà in una valle di lacrime, cioè lontano dal compimento di sé e dalla confidenza, finché non lo raggiungerà la morte. Il Tonalestate, per il suo manifesto del 2009, ha scelto Caino e Abele raffigurati da Chagall, pittore angelico, che guarda con lo stupore di un bambino l’apparire della violenza nel mondo umano. E proprio grazie a questo suo innocente sguardo, noi ci domandiamo, senza saper trovare una risposta a tutte le violenze e le ingiustizie della storia: “Come mai?”. Vorrei soffermarmi su quel segno che Dio ha posto sulla fronte di Caino prima di allontanarlo: quel segno è la voce invocante nelle tenebre di cui parla lo scrittore svedese Par Lagerkvist nella poesia che accompagna il quadro di Chagall sul manifesto del Tonalestate. Se Caino si fosse potuto togliere quel segno dalla fronte (o altri avessero potuto toglierglielo) sarebbe stato ucciso: ma quel segno è indelebile, quella voce invocante nelle tenebre non si può né si potrà mai eliminare. Quel segno, che salverà Caino della morte violenta, è la nostra arma di difesa: quella voce invocante nelle tenebre salverà l’uomo da poteri transitori e intimidanti. Ed è proprio quella voce invocante nelle tenebre a porre al poeta, e con lui a ciascuno di noi, la domanda chiave per l’uomo d’oggi, dalla quale ripartire: “Perché giace una creatura nel fondo delle tenebre e invoca qualcosa che non esiste?”.
L’ EVOLUTO SELVAGGIO L’ evoluto selvaggio è l’uomo del nostro tempo che, benvestito, sentendosi molto sicuro di sé, pur vedendo quel segno sulla fronte dell’altro, decide di ignorarlo e, schiavo del suo stesso auto-potere, decide di sfidare la protezione che il Dio riserva a ogni uomo. Da che mondo è mondo, sono molte, sono troppe e sempre le stesse le forme in cui l’uomo si scaglia sull’altro uomo, allorché ha scelto di vivere la selvaggia indifferenza alle leggi dell’essere. A chi dicesse che oggi siamo più civili e meno disumani che in passato, consiglio di andare a Guantànamo, a vedere come vanno le cose; o di farsi un giro in un campo di concentramento cinese, dove un uomo o una donna o un bambino (nostri fratelli) viene ucciso a sangue freddo per venderne gli organi ai ricchi magnati in difficoltà di salute. Oppure di andare in Afghanistan, in Iraq, o nei paesi in guerra per poter essere riconosciuti come popolo o nazione. Siamo meno selvaggi? Pensiamo alle recenti guerre di conquista, alle torture usate per ottenere informazioni o per punire i ribelli; pensiamo alle malattie che gli scienziati appositamente creano in laboratorio e vengono poi diffuse nell’ambiente, mentre manodopera a basso costo distribuisce gli antivirus agli ospedali e alle farmacie, per poter così guadagnare tanti soldi. Ma pensiamo anche alla delicata raffinatezza del delitto che c’è sempre stata e c’è ancora: ai delitti di stato, ai delitti bancari e finanziari, delitti per i quali interi popoli scontano ingiustamente la pena mentre i colpevoli se la ridono perché, come si dice in Messico, “lo bailado nadie te lo quita”. Commentando i recenti fatti del colpo di stato nel loro paese, alcuni amici in Honduras hanno detto: “Questa catastrofe non è prodotta dalle viscere della natura o dalla pur colpevole incuria dell’uomo; questa è prodotta dall’espressa volontà umana di potere”. Il potere e la sua logica – che investe come una piovra i rapporti tra padre e figlio, tra madre e nuora, tra maestro e alunno, tra potenti e oppressi – sono sempre stati e sono ancor oggi il vero male delle nostre società, nelle quali ciascuno di noi non è che un numero di registro che paga le tasse, mentre lo stato spera che il cittadino muoia prima di aver diritto alla pensione. E’ la logica del potere che ha come conseguenza ineliminabile l’incuria: verso il pianeta e il suo universo, verso i piccoli, verso i giovani, verso tutto ciò che ha ancora una goccia del sapore dell’innocenza. Ho visto un cartello appeso in una città italiana che diceva: “Si stava MEGLIO quando si STARA’ meglio”. Un nonsense pieno di senso, dove il presente è sottaciuto tra un imperfetto e un futuro, ma dove il meglio non è dimenticato. A cercare quale potrebbe essere il meglio (e non più il meno peggio) dobbiamo impegnarci tutti, e sul serio e in fretta.
C’È DUNQUE UN RIMEDIO? L’uomo, diceva Pico della Mirandola nel suo Discorso sulla dignità dell’uomo, ha la possibilità di diventare o come Dio o peggiore di una bestia. È il gran dramma e il gran dono della libertà e del tempo d’esistere che Dio concesse anche a Caino. In questo senso l’uomo può diventare “più uomo” o “meno uomo”, secondo ciò che decida di fare della sua vita. Ma riesce, forse, l’uomo, da solo, a non lasciarsi sottomettere da una civiltà che gli ruba il portafoglio insieme al cervello e che ammazza non solo o non sempre il corpo, ma va sempre diretta col suo staffile all’anima? Guardarsi dalla società e soprattutto dalla logica del potere è una delle decisioni più semplici, ma più faticose, da prendere e richiede somma attenzione e attenta vigilanza da parte di ogni uomo. Avere almeno coscienza di questo lavoro da fare è l’inizio del rimedio. E’ un lungo cammino educativo. Dante, nel suo viaggio all’Inferno, incontra Brunetto Latini, che fu suo maestro. Gli dice Dante: “Mi dà coraggio la vostra cara, buona e paterna immagine di quando, nel mondo dei vivi, mi insegnavate come l’uom s’etterna”. Il rimedio c’è, dice Dante: lasciarsi educare all’eterno.